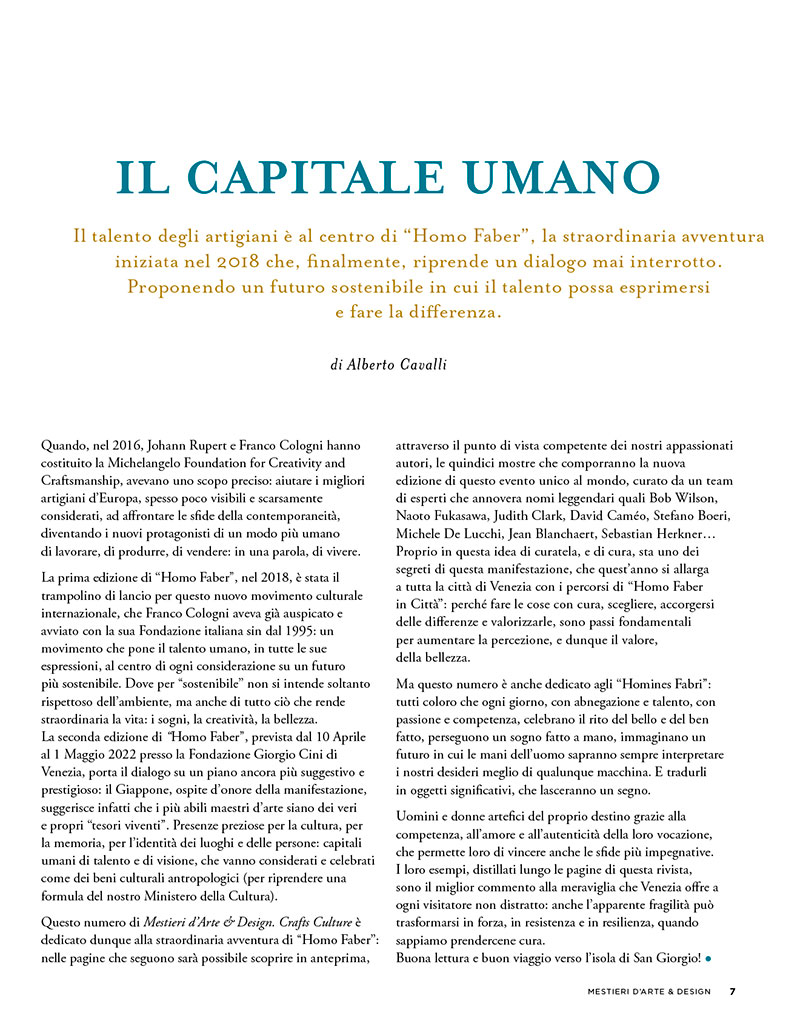Pietro fu Stefano. Punto a capo.
Esiste un modo più sublime di nominare – letteralmente – la tradizione? Sono in quanto sono stato. Sono oggi perché sono generato, adesso.
È quello che accade a Genova, da sette generazioni, in un opificio dolciario. Oggi tocca a Pietro Romanengo – nipote di Stefani e di Pietri – portare il dolce peso che i suoi avi gli hanno consegnato. «Un luogo che non poteva che nascere che qui,» ama ribadire l’attuale “tedoforo”. Qui a Genova, grazie al suo porto e al suo rapporto con l’Asia, grazie alla cultura araba alla possibilità di esportare nel mondo ma soprattutto grazie alla maestria tutta italiana di usare lo zucchero per conservare la natura e per imitare la natura. Italians do it better, si sa.
Romanengo sublima le materie prime, trasformandole in nobili prodotti zuccherini. Elogio della confetteria e sapienza magistrale nella bottega in cui il tempo si è fermato.
Tutto ciò che riempie il naso e che si vede entrando nel laboratorio di via Mojon a pochi passi dalla stazione di Brignole sa di alchemico, sa di nobile, sa di gratitudine. Non chiamatela azienda ma laboratorio e non chiamateli reparti ma botteghe. Bottega sulla scorta della genesi di queste specialità nate da uomini geniali che facevano e all’unisono vendevano mostrando l’arte del saper fare. Dal 1780, qui si fanno canditi nella bottega segreta della canditura, cercando di fissare l’anima del frutto in una sapiente crisalide di glassa zuccherina. In questo spazio si alternano le stagioni che entrano impetuose e frettolose per essere “immortalate”, le sapienti lavorazioni sono frutto – anche loro – di conoscenza della materia viva e delle qualità dello sciroppo. Fichi, marroni, mandarini, arance, chinotto, petali di rosa, frutti e fiori si preparano a diventare più preziosi a perdurare.
Nella bottega della confettatura lo zucchero che gira nella bassina, ipnotico, cristallizza spezie e scorze. Qui tutto è sapienza, pozione e pazienza. Pinoli di Pisa, mandorla di Avola ma anche cardamomo e cannella e l’Oriente così continua il suo racconto di sé in questa città. Poi il mestiere diventa ambizione e la natura non solo si può conservare ma addirittura mimare ed è subito caramella, una parola antica che merita una reverenza speciale e andrebbe salvata e strappata dalla banalità in cui è decaduta. Dura, gommosa, gelatinosa. La caramella, la confetteria è un gioco molto serio, va immaginata in un mondo in cui generava emozione, era come colore in un ambiente in bianco e nero, ma anche oggi, il palato non mente quando si incontra qualcosa di magistrale è lì che si fissa un punto di non ritorno, che si comprende l’altezza della gastronomia, che si fa un passo di conoscenza. “Zuccherini” li abbiamo vissuti tutti da bambini ma assaggiare un fondant o una ginevrina o una goccia di rosolio da adulti è altra faccenda.
Girando tra le botteghe di questo opificio tante cose vengono alla mente: la città di Genova e la sua unicità, le guerre da quelle napoleoniche a quelle recenti che hanno condizionato e plasmato questo luogo e la storia della famiglia Romanengo, l’etimologia di certi strumenti e certi gesti ma una cosa manca o meglio, si perde qui dentro ed è il tempo. Scandito solo da un incessante stantuffo di una macchina che da oltre un secolo è adibita al concaggio della “fabbrica di cioccolato”. Un concaggio lento, inesorabile e limitato a soli circa cento chilogrammi di cioccolato alla volta perché così si ha il lusso di poter aggiungere null’altro. Le tavolette fatte a mano, la stagnola avvolta a mano, la scatola in cui a mano viene inserito il prodotto ha un disegno fatto a mano.
È per tutti questi motivi che questo luogo potrebbe essere un set di un romanzo e dovrebbe essere destinazione di gita scolastica dei professori però prima che degli studenti. Questo luogo è un patrimonio nazionale, e chi lo anima è un tesoro vivente. Eppure è uno spazio in attesa di un nuovo rinascimento, un atelier la cui scoperta lascia spaesati come se ci fosse qualcosa da decifrare ma non con la velocità dei tempi correnti, tra l’orgoglio di essere parte di questa storia per il semplice fatto di essere italiani, il rammarico che non venga adeguatamente raccontato e la vena malinconica che bene il genio di Charles Peguy ha espresso nel suo libro L’Argent e che non possiamo che dedicare alla Famiglia Romanengo ringraziandoli di resistere.
«Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso principio delle cattedrali. E sono solo io – io ormai così imbastardito – a farla adesso tanto lunga. Per loro, in loro non c’era allora neppure l’ombra di una riflessione. Il lavoro stava là. Si lavorava bene.
Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto. Un sentimento incredibilmente profondo che oggi definiamo l’onore dello sport, ma a quei tempi diffuso ovunque. Non soltanto l’idea di raggiungere il risultato migliore possibile, ma l’idea, nel meglio, nel bene, di ottenere di più. Si trattava di uno sport, di una emulazione disinteressata e continua, non solo a chi faceva meglio, ma a chi faceva di più; si trattava di un bello sport, praticato a tutte le ore, da cui la vita stessa era penetrata. Intessuta. Un disgusto senza fine per il lavoro mal fatto. Un disprezzo più che da gran signore per chi avesse lavorato male. Ma una tale intenzione nemmeno li sfiorava. Tutti gli onori convergevano in quest’unico onore. Una decenza, e una finezza di linguaggio. Un rispetto del focolare. Un senso di rispetto, di ogni rispetto, dell’essenza stessa del rispetto. Una cerimonia per così dire costante. D’altra parte, il focolare si confondeva ancora molto spesso col laboratorio e l’onore del focolare e l’onore del laboratorio erano il medesimo onore.
Era l’onore del medesimo luogo. Era l’onore del medesimo fuoco. Cosa mai è divenuto tutto questo. Ogni cosa, dal risveglio, era un ritmo e un rito e una cerimonia. Ogni fatto era un avvenimento; consacrato. Ogni cosa era una tradizione, un insegnamento; tutte le cose avevano un loro rapporto interiore, costituivano la più santa abitudine. Tutto era un elevarsi, interiore, e un pregare, tutto il giorno: il sonno e la veglia, il lavoro e il misurato riposo, il letto e la tavola, la minestra e il manzo, la casa e il giardino, la porta e la strada, il cortile e la scala, e le scodelle sul desco. Dicevano per ridere, e per prendere in giro i loro curati, che lavorare è pregare, e non sapevano di dire così bene.»